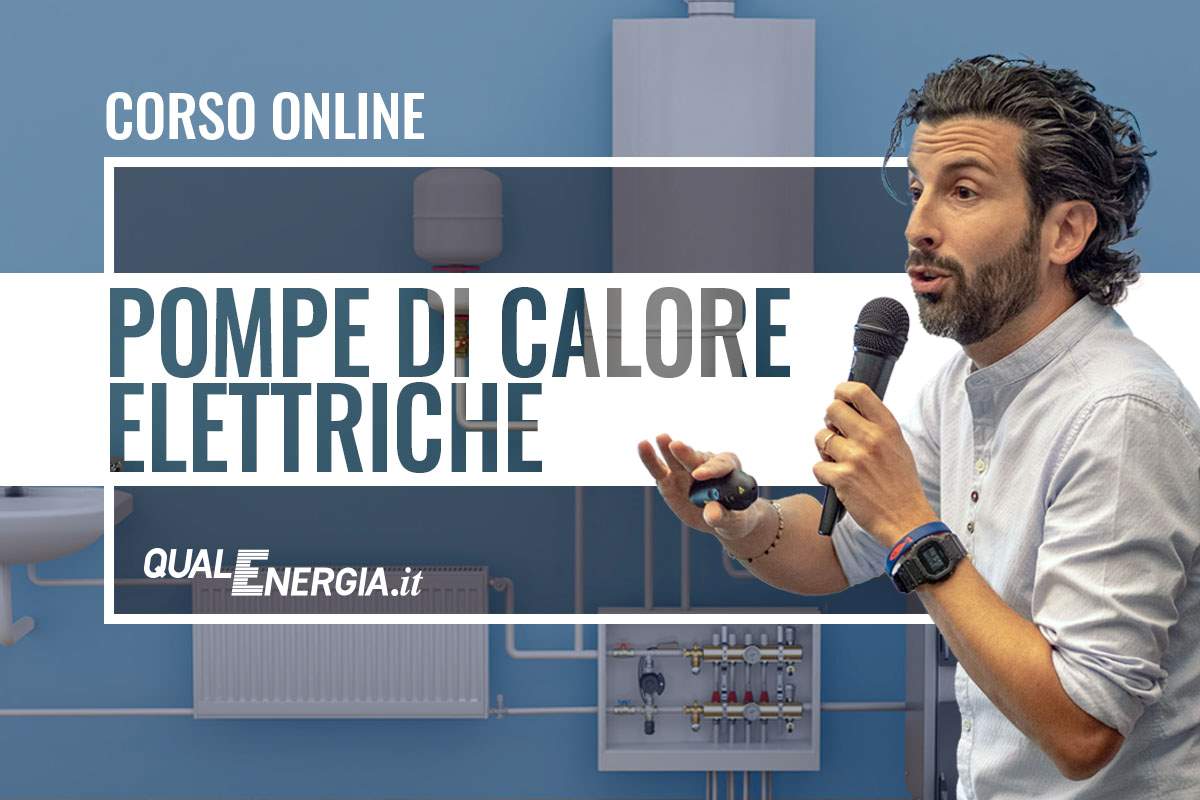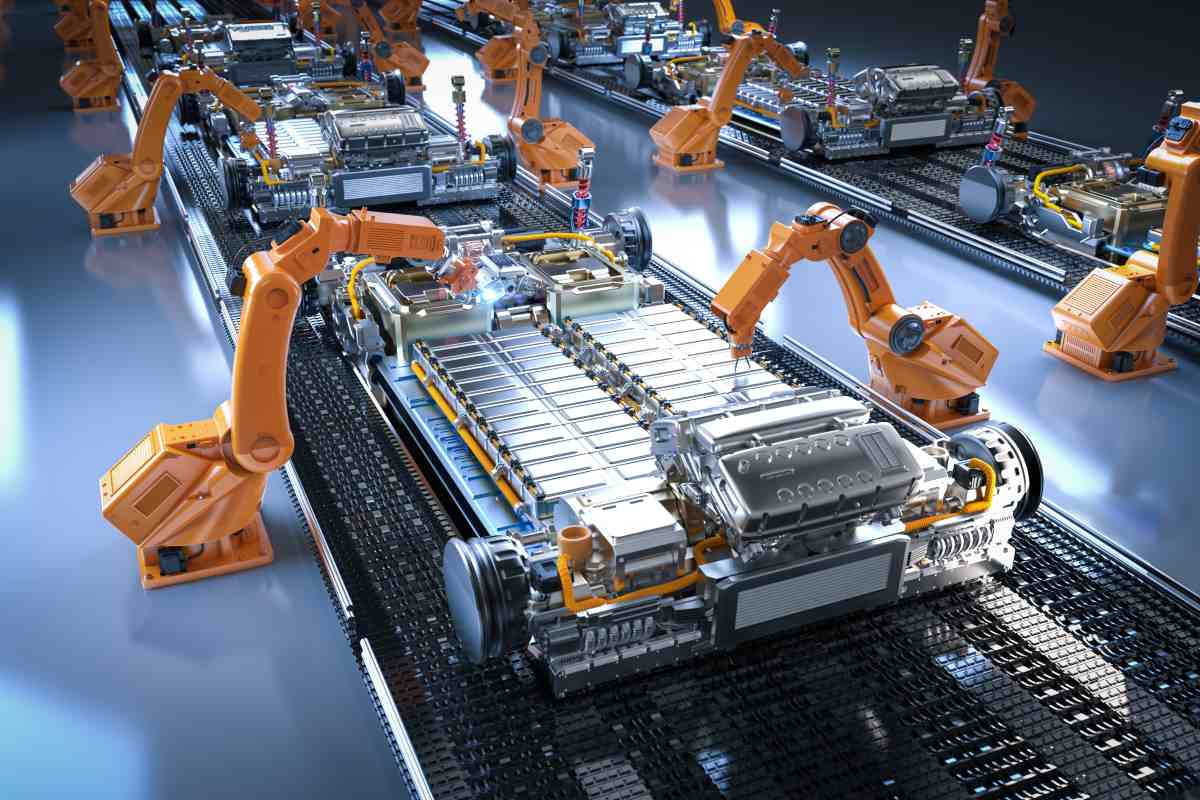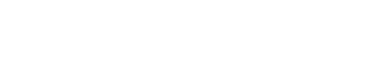Se l’Unione europea vuole essere pienamente preparata ad affrontare una nuova crisi del gas, simile a quella generata dalla guerra in Ucraina, c’è ancora molta strada da fare.
Le misure di emergenza adottate in risposta alla chiusura delle forniture di gas, usata come arma di ricatto da parte della Russia di fronte alle sanzioni Ue, hanno aiutato gli Stati membri ma i benefici “non sono sempre chiari”. Lo afferma la Corte dei conti europea in una relazione pubblicata lunedì 24 giugno (link in basso).
Il 2022, ricordiamo, ha visto i prezzi del gas aumentare di sei volte in Europa e i Paesi si sono affrettati a sovvenzionare le bollette per non far gravare il costo degli aumenti sui cittadini, senza però definire interventi più strutturali di riforma del mercato energetico.
Ora che i prezzi si sono nuovamente stabilizzati, la Corte ha riscontrato, in linea generale, che il contributo comunitario alla crisi non può essere facilmente identificato e che le norme sulla solidarietà transnazionale necessitano di modifiche.
Nel pieno dell’emergenza, l’Ue ha raggiunto l’obiettivo di ridurre la domanda di gas del 15%, ma gli analisti della Corte non sono stati in grado di stabilire se ciò sia stato dovuto alle sole misure adottate o anche a fattori esterni, come ad esempio gli alti prezzi del gas e un inverno mite.
Allo stesso modo, l’obbligo di riempimento degli impianti di stoccaggio del gas in tutto il Continente è stato rispettato, con l’obiettivo del 90% che è stato addirittura superato. In pratica, viene fatto però notare, si tratta dei normali livelli di riempimento presenti anche prima della crisi, che riflettono quindi tendenze storiche.
Inoltre, è impossibile valutare l’efficacia del tetto al prezzo del gas, “dato che i prezzi si sono mantenuti bassi dopo che è stato introdotto”.
Tra le altre misure adottate, c’è stato il lancio della piattaforma AggregateEU per fornire un canale alternativo per gli scambi di gas, anche attraverso acquisti congiunti.
Anche in questo caso, non è stato possibile stabilire se la piattaforma abbia fornito un valore aggiunto, dato che le differenze di prezzo tra gli Stati membri dell’Ue, indotte dalla crisi, si erano già fortemente ridotte quando AggregateEU è entrata in attività.
Il progetto ha suscitato inizialmente grande coinvolgimento da parte degli acquirenti, che hanno utilizzato la piattaforma per segnalare il proprio interesse all’acquisto di un equivalente di gas pari al 50% della capacità di stoccaggio dell’Ue. Tuttavia, la Commissione non aveva il diritto di accedere ai contratti di fornitura risultanti da queste offerte, quindi non è noto quanto gas sia stato effettivamente assicurato grazie alla piattaforma.
La falla nella cooperazione
La Corte evidenza le nuove sfide che l’Ue deve affrontare se vuole garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas a lungo termine. “Dato che l’Ue dipende dal gas estero, non può mai adagiarsi sugli allori quando si tratta di sicurezza dell’approvvigionamento. E i consumatori non hanno alcuna garanzia in merito alla sua accessibilità economica, in caso di una futura grave penuria”, ha affermato João Leão, il membro della Corte responsabile dell’audit.
Guardando al futuro, la Corte conclude che l’Ue debba consolidare il quadro normativo sull’accessibilità economica del gas, ottimizzare il processo di stesura delle relazioni sulla sicurezza dell’approvvigionamento, rivedere la struttura della cooperazione regionale e migliorare la trasparenza nell’attuare i progetti di interesse comune.
Molti Stati membri, infatti, sarebbero ancora riluttanti a firmare accordi bilaterali di solidarietà. Alcuni Paesi, sostiene la Corte, taglierebbero persino le forniture di gas a un Paese vicino in caso di emergenza. Anche il quadro di solidarietà andrebbe quindi immediatamente rivisto.
Al culmine della crisi energetica del 2022, ricordiamo ad esempio come la Germania fece appello ai contratti di solidarietà per riuscire a garantire il suo approvvigionamento energetico, ma con scarso successo.
Il piano europeo per le infrastrutture
Oltre alle questioni politiche, la sicurezza degli approvvigionamenti energetici europei passa anche per le infrastrutture critiche. Basti pensare alle conseguenze dell’attacco al gasdotto Nord Stream. Ed è per questo che ieri, 25 giugno, il Consiglio europeo ha pubblicato alcune raccomandazioni (link in basso) per “un programma per coordinare una risposta a livello dell’Unione alle perturbazioni delle infrastrutture critiche con significativa rilevanza transfrontaliera”.
“I cittadini e le imprese fanno affidamento sul funzionamento di gasdotti, centrali elettriche e snodi di trasporto. Quando queste e altre infrastrutture critiche sono a rischio, l’Ue ha bisogno di una guida su come rispondere in modo rapido ed efficace”, ha dichiarato Annelies Verlinden, ministra degli Interni belga e presidente di turno del Consiglio Ue Affari generali.
La raccomandazione istituisce quindi un piano per le infrastrutture critiche, allo scopo di promuovere una consapevolezza condivisa sulle origini e le conseguenze di un eventuale incidente, rafforzare il coordinamento delle comunicazioni pubbliche e definire una risposta efficace.
Il piano raccomanda diverse azioni, come la condivisione delle informazioni, il coordinamento con altri meccanismi di crisi ed emergenza dell’Ue, lo scambio di approcci di comunicazione pubblica, la preparazione di rapporti sugli incidenti e il supporto tecnico fornito da altri Stati membri o istituzioni dell’Ue agli Stati membri colpiti.













.gif)