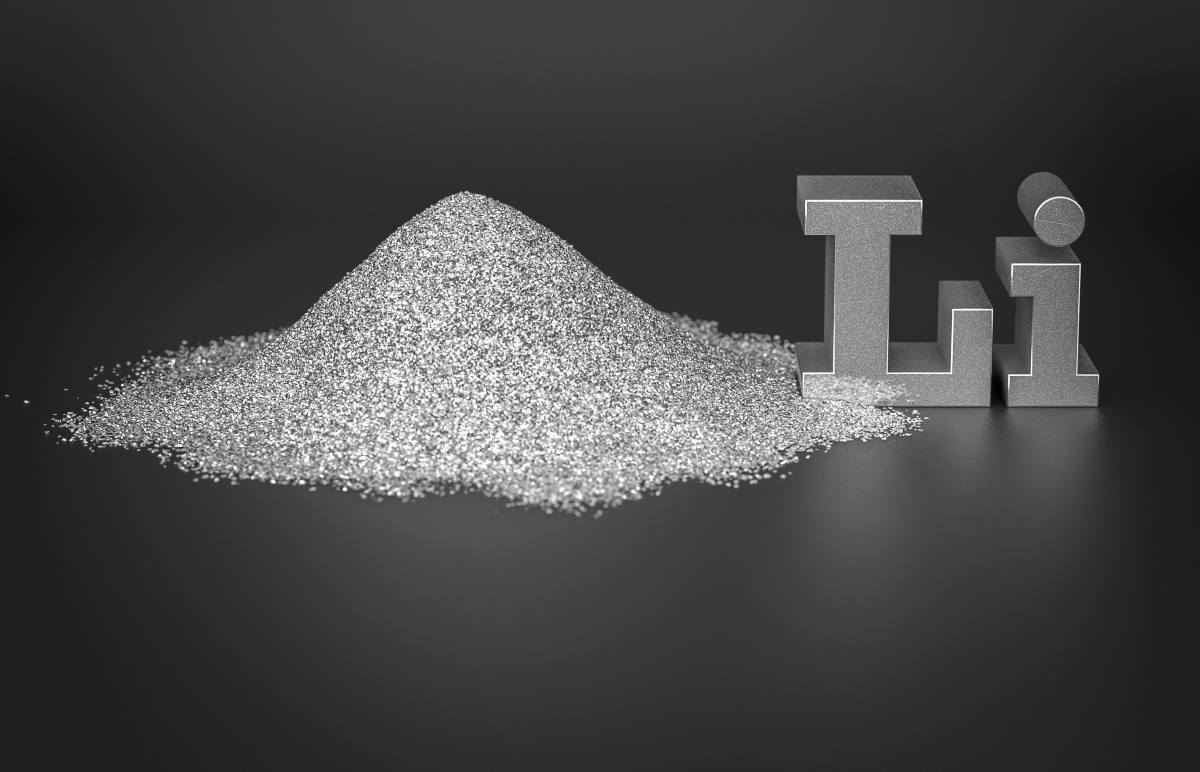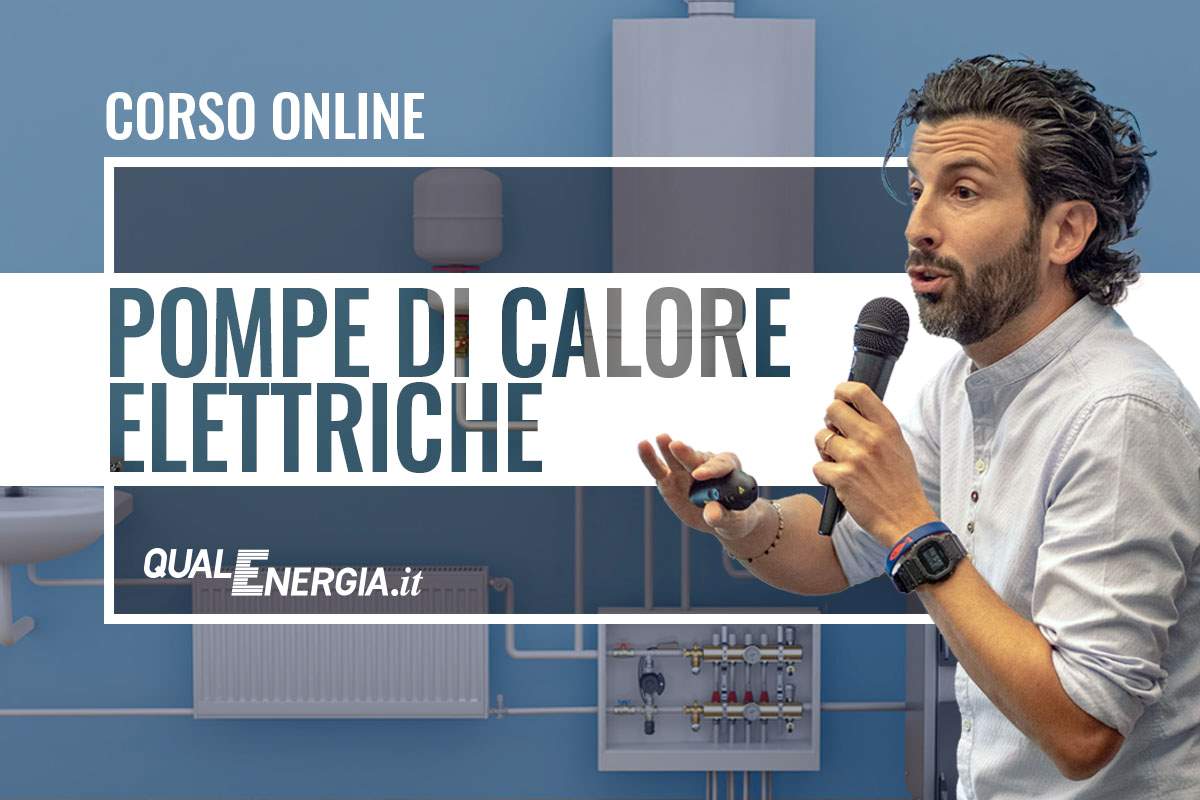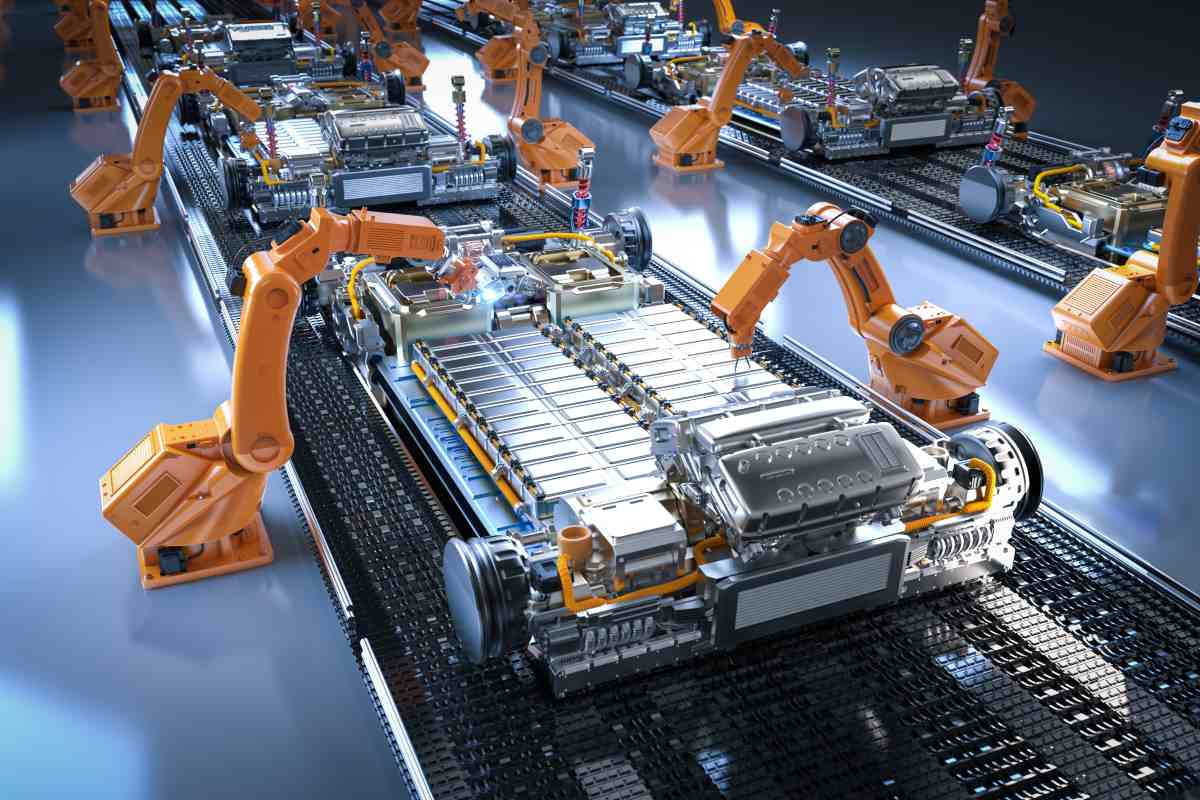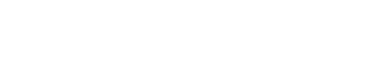In Italia il potenziale di estrazione del litio non è mai stato esplorato a fondo.
Si sa che è presente, e anche in elevante concentrazioni, all’interno dei fluidi geotermici laziali-campani ma anche nei fluidi salini termali del limite dell’Appennino con la pianura Padana e con la costa Adriatica. Ci sono poi possibili target in rocce e minerali delle Alpi, della Toscana, in Sardegna e in Calabria.
Ma una normativa di riferimento vecchia di quasi cento anni (il Regio Decreto 29 luglio 1927 n. 1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere”) e la scarsità di sostegni per la mitigazione del rischio bloccano le attività esplorative senza le quali nessuna azienda è in grado di elaborare progetti di fattibilità economica e ambientale per trasformare i permessi di ricerca in concessioni minerarie.
Tutti i giacimenti sono al momento “target potenziali”, spiega a QualEnergia.it Andrea Dini, Primo ricercatore dell’Istituto di Geoscienze e Georisorse del Cnr, che aggiunge: “Fino a che non verranno esplorati dalle compagnie minerarie non sapremo mai se si tratta di giacimenti utilizzabili”.
Le esplorazioni mancate
La presenza di notevoli concentrazioni di litio nei fluidi geotermici del Lazio e della Campania è nota da oltre 40 anni. Durante le attività di esplorazione geotermica portate avanti dall’Enel negli anni ’70 e ’80 furono intercettati, ad alcune migliaia di metri di profondità, dei fluidi salini caldi che furono campionati e analizzati.
I dati furono pubblicati in alcuni articoli scientifici e report. Su tutti lo studio del 2022 (pdf) condotto proprio da Dini e altri ricercatori dell’Istituto di Geoscienze e Georisorse e del Cnr, secondo il quale tra Toscana, Lazio e Campania ci sarebbero fluidi geotermici con concentrazioni di litio fino a 480 mg/l, mentre lungo gli appennini tra Alessandria e Pescara ci sarebbero manifestazioni termali con contenuti in litio fino a 370 mg/l associati a giacimenti di idrocarburi.
Valori che sono tra i più alti riscontrati nei fluidi profondi del pianeta. Le concentrazioni massime riscontrate in altri Paesi si aggirano infatti sui 200-250 mg/l.
“Purtroppo i pozzi sono stati chiusi e non è più stato possibile ottenere campioni di quei fluidi profondi”, aggiunge Dini.
L’Italia, leader nella ricerca e sfruttamento dei fluidi geotermici, avrebbe know-how e basi di conoscenza storiche per sviluppare l’intera filiera geotermica, “ma l’interesse per l’attività mineraria nel nostro Paese è andato scemando a partire dalla fine degli anni ’80, fino a scomparire definitivamente subito dopo il 2010”, ci spiega Emanuele Emani, Consigliere del Consiglio nazionale dei geologi e coordinatore della Piattaforma geotermia.
Le importazioni dalla Cina hanno fatto scendere l’interesse verso la ricerca, così molte imprese stanno provando a colmare il divario istituendo joint-venture con aziende straniere esperte nel settore.
“Alcune società hanno una grande esperienza nel campo della geotermia a livello globale – aggiunge Emani – e hanno un notevole potenziale di applicazione anche nel campo del litio geotermico. Valorizzare le aziende nazionali leader nel settore, oltre che normare azioni che possano facilitare l’ingresso di capitali e di conoscenze estere, potrebbe compensare in breve tempo il gap scientifico e industriale che si è creato negli ultimi 30-40 anni di abbandono delle attività minerarie nel nostro Paese”.
Due esempi mostrano perfettamente questo trend. Vulcan Energy, azienda australiana, ha ottenuto un permesso di ricerca in collaborazione con Enel per esplorare, nel Lazio, un pozzo scoperto nel 1974 a circa 1.390 metri di profondità. Lo scorso marzo un’altra società australiana, Altamin Limited, e la multiutility italiana Iren hanno firmato un memorandum d’intesa per il recupero del litio dalle salamoie geotermiche nell’ambito dell’Altamin’s Geothermal Lithium Project attivo anch’esso nel Lazio.
Norme antiquate e una “sponda” europea
L’ostacolo più grande resta il mancato aggiornamento della normativa. Come detto, la legge nazionale di riferimento è il Regio Decreto 29 luglio 1927 n. 1443. Nel 2020 le competenze sono state trasferite alle Regioni. Ma allo stato attuale, secondo il D.Lgs. 22/2010, si rimanda al Regio Decreto del ’27 qualora il valore economico del litio estratto dalle salamoie geotermiche risulti superiore al valore economico dei kWh termici del fluido che lo contiene.
“Pertanto, per avere un quadro normativo moderno che consideri la necessità di contemplare l’esigenza di rendere i lavori compatibili sotto il profilo della sostenibilità ambientale, economica e sociale, è urgente una nuova legge sulle attività minerarie o quantomeno una profonda rivisitazione di quella esistente”, incalza Emani. A questo proposito, il Ministero del Made in Italy ha fatto sapere di avere allo studio un decreto sulle concessioni minerarie che potrebbe snellire gli iter autorizzativi.
Un aggiornamento che avrebbe bisogno anche di una “sponda” europea. Appena lo scorso 5 giugno l’European Geothermal Energy Council (Egec) ha pubblicato un manifesto per chiedere una strategia geotermica comunitaria, analogamente a quanto fatto per le altre energie rinnovabili, che affronti tutte le difficoltà del settore proponendo le relative soluzioni, tra cui l’armonizzazione e lo sviluppo di nuovi regimi di sostegno, comprese le garanzie transfrontaliere sui rischi finanziari, e una maggiore accessibilità dei dati geologici.
Un passo in avanti ritenuto indispensabile anche alla luce del Critical Raw Materials Act europeo (Crma), che punta a rendere l’Europa indipendente nelle materie critiche attraverso lo sviluppo della produzione e lavorazione in loco.
Secondo i promotori della legge, entro il 2030 il consumo annuale del blocco Ue sarà composto per almeno il 10% da minerali estratti localmente, per il 40% da elementi lavorati all’interno dell’Ue e per il 25% da materiali riciclati.
Allo stesso tempo, nessun Paese terzo fornirà più del 65% del consumo annuale europeo di uno qualsiasi dei materiali chiave. In relazione al permitting, dal Crma emerge la necessità di avere un’autorità competente che rappresenti un unico punto di contatto per la gestione, il monitoraggio e la finalizzazione dei titoli minerari.
Per quelli che verranno valutati come “Progetti Strategici” si impone inoltre un limite temporale per il rilascio del titolo concessorio, prevedendo quindi una velocizzazione dell’iter.
Dovessero quindi concretizzarsi i progetti estrattivi, all’Italia verrebbe chiesto di non esportare il litio, ma di lavorarlo all’interno dei confini Ue per trasformarlo in componenti essenziali per la transizione energetica, su tutti le batterie.
Le aziende interessate ci sarebbero, quello che manca è la capacità di fare impresa mineraria”, insiste Dini. “Ci vuole coraggio, insieme a una normativa che permetta di avere rapidamente risposte. Se devo investire 200 milioni non posso avere 10-15 anni di incertezza e di attesa prima di ottenere un permesso di ricerca”.