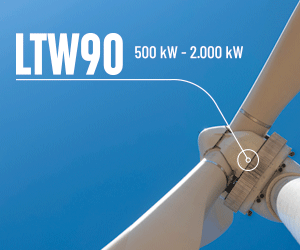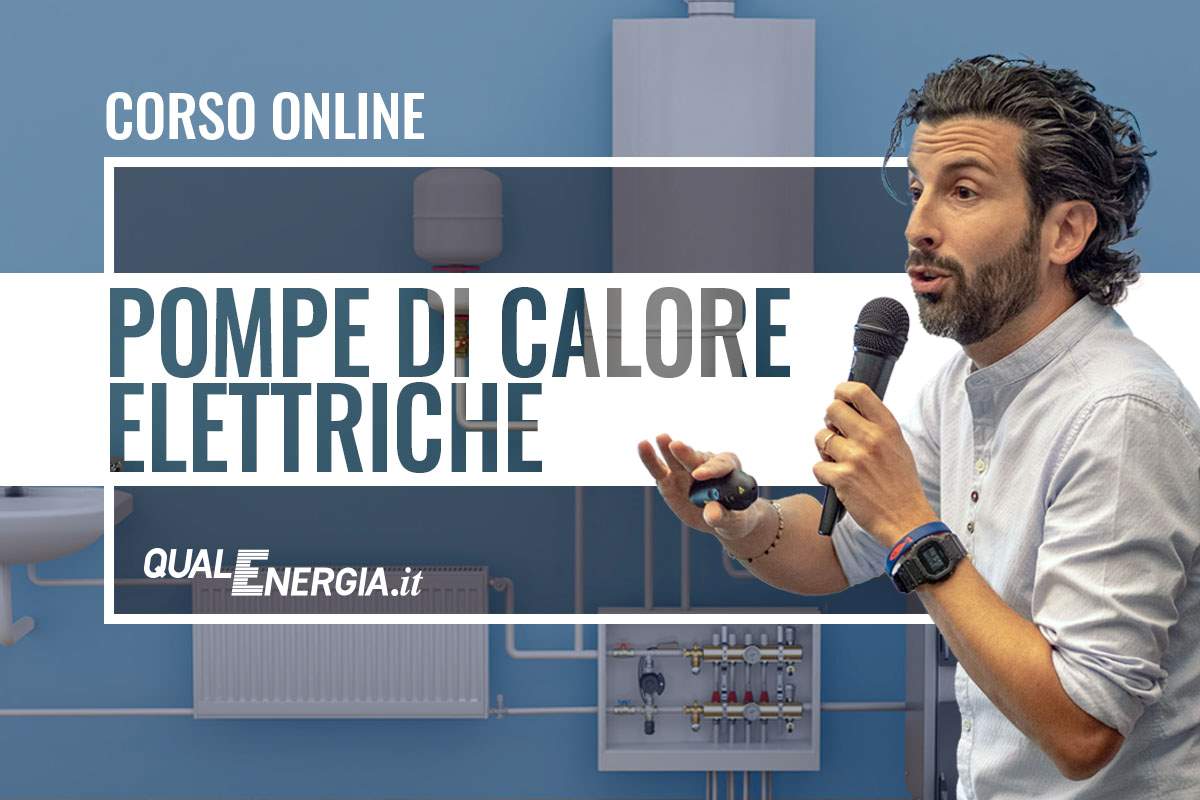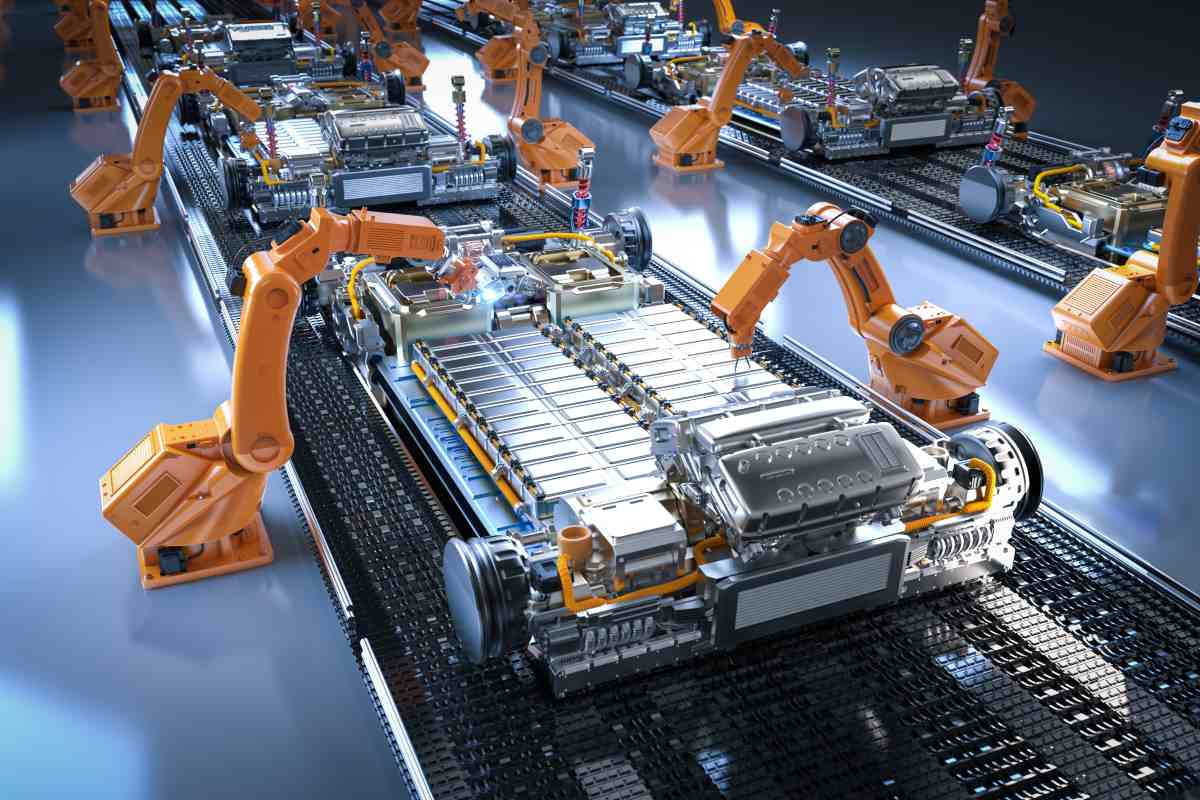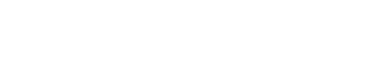Portata dei fiumi italiani, come il Po, ridotti di 4 o 5 volte, siccità, razionamento dell’acqua nelle aree urbane, problemi alle colture agricole.
Anche nel nostro paese la crisi idrica e l’accesso all’acqua sta diventando un altro fattore di una crisi sistemica di cui non conosciamo ancora gli sviluppi a breve. Immaginiamo però cosa potrà causare nel medio-lungo periodo su scala mondiale in termini di conflitti e crisi umanitarie.
La disponibilità di acqua insieme all’energia e ai cambiamenti climatici sono questioni strettamente connesse. Saranno le sfide dei prossimi decenni e dovremo tutti lavorare in questa direzione, anche se stiamo perdendo tempo. Se non lo facciamo subito corriamo il rischio di avere anche perdite economiche difficilmente quantificabili.
Il problema dello stress idrico è destinato a peggiorare nei prossimi anni, a causa di diversi fattori, tra cui l’incremento di domanda energetica, i cambiamenti climatici, la sovrappopolazione urbana.
La relazione tra energia e acqua è molto più forte di quanto si pensi e riguarda tutte le fonti, sia fossili che rinnovabili. Già nel 2018 un’analisi del World Resources Institute (WRI) non lasciava dubbi fin dal titolo “No Water, No Power“.
Le scarse precipitazioni potranno così creare problemi di adeguatezza per il mercato elettrico, sia per l’idroelettrico ma anche per le centrali termoelettriche: reattori nucleari, unità a gas, a carbone e a biomasse sono impianti che richiedono moltissima acqua per molteplici esigenze, ad esempio per i sistemi di raffreddamento e per generare vapore; acqua che in molti casi è prelevata direttamente da fiumi e laghi situati nelle vicinanze.
Lo studio stimava che in Europa la generazione termoelettrica potrebbe calare del 19-20% dal 2030 al 2060 per via degli impatti climatici, con la conseguente crisi delle forniture idriche.
In questi giorni in Italia lo stato di emergenza idrica ha imposto la fermata di quasi 2000 MW di centrali termoelettriche: 1.154 MW di Sermide (A2A), un gruppo da 400 MW di Ostiglia (EP Produzione) e un gruppo da 400 MW di Moncalieri (Iren). Ma a rischio ci sono altri 4.600 MW.
Investire maggiormente nell’eolico e nel fotovoltaico, oltre a costruire un mix energetico a basso contenuto di CO2, consente al tempo stesso di ridurre il consumo di acqua e di minimizzare la competizione tra differenti utilizzi del prezioso liquido: produzione energetica, agricoltura, usi industriali e domestici. La generazione solare richiede ad esempio solo il 2-15% dell’acqua utilizzata dalle centrali a carbone e nucleari per ogni megawattora prodotto.
Per gli impianti termoelettrici bisognerà puntare su tecnologie di raffreddamento ad aria o acqua marina desalinizzata e sistemi di recupero-riciclo dell’acqua.
Qualche anno persino la IEA aveva indicato la necessità di ridurre la produzione su vasta scala di biocarburanti, lo sviluppo di nuovi reattori nucleari e la realizzazione di grandi impianti solari termodinamici, sistemi che richiedono un notevole apporto di acqua.
Sempre il WRI ha valutato che dati di questo tipo sarebbero fondamentali per pianificare in modo corretto l’installazione di nuove fonti di energia, ma non è semplice ottenere queste informazioni da molti paesi.
Per questo ha elaborato un metodo basato sul raffronto delle immagini satellitari, per individuare gli impianti termoelettrici e le rispettive caratteristiche dei sistemi di raffreddamento, per poi combinare le stime empiriche sull’intensità dei prelievi idrici delle singole centrali con i dati sulla generazione elettrica, calcolando, infine, in modo approssimativo la quantità d’acqua prelevata-consumata in un certo periodo.
Nel documento “A methodology to estimate water demand for thermal power plants in data-scarce regions using satellite images“, il metodo è stato testato su 200 impianti negli Stati Uniti con un’accuratezza del 90% per quanto riguarda l’identificazione del tipo di carburante/sistema di raffreddamento, e una precisione intorno al 69% sulle stime della domanda idrica, secondo la maggiore o minore disponibilità di dati sulla produzione elettrica.
Garantire a tutti acqua dolce a prezzi accettabili e utilizzare le fonti rinnovabili nei processi di dissalazione saranno tra le azioni prioritarie nell’agenda dei governi nazionali e locali.
Nel 2030, secondo lo Stockholm International Water Institute, circa il 47% della popolazione mondiale potrebbe avere problemi di scarsità di acqua.
La dissalazione di acqua di mare è una valida alternativa, come dimostra il caso di Israele, che già recupera dal mare il 20% della sua acqua potabile.
Tuttavia, questi impianti e processi dovranno essere realizzati nel rispetto degli ecosistemi naturali. Infatti, uno dei loro problemi ambientali è lo scarico in mare della salamoia, residuo del processo di dissalazione: una soluzione ad alta concentrazione di sale che può essere molto dannosa.
Peraltro, il costo medio globale livellato dell’acqua potabile (LCOW) proveniente dagli impianti di desalinizzazione è ancora molto elevato anche se con l’utilizzo di fotovoltaico, sistemi di accumulo e altre energie rinnovabili si potrebbe dimezzarlo entro un paio di decenni.
È uno dei risultati di uno studio “Strengthening the global water supply through a decarbonized global desalination sector and improved irrigation systems”, condotto un paio di anni fa dalla Lappeenranta University of Technology (LUT) in Finlandia.
Secondo lo studio, condotto dal docente di economia solare Christian Breyer e dal suo team, il costo dell’acqua dissalata nella maggior parte delle regioni potrebbe variare da 0,32 euro al metro cubo a 1,66 euro entro il 2050, comprese le spese di consegna.
Oltre a fotovoltaico e sistemi di accumulo, anche l’energia eolica, il gas e l’energia termica alimenteranno le operazioni di desalinizzazione, secondo lo studio LUT, che ha considerato in ogni fase del processo anche la domanda di energia per trasportare l’acqua desalinizzata dalla costa verso l’interno.
Tuttavia, Breyer aveva descritto come un sistema energetico globale basato sulle energie rinnovabili ridurrebbe di oltre il 95% il consumo di acqua legato alla produzione di energia convenzionale.
Nel frattempo, in Italia dovremmo sistemare il nostro sistema idrico, con reti che perdono, in certe zone, anche la metà dell’acqua che trasportano. Si potrebbero poi usare filtri e sistemi a membrana, per depurare le acque fognarie, recuperando grandi volumi di acqua dolce oggi gettati in mare.
Ma visto che la piovosità media e il manto nevoso continuerà a ridursi nei prossimi due decenni investire anche in Italia nell’industria della dissalazione sarà una strategia necessaria per non dipendere poi da altri paesi anche su questa tecnologia.